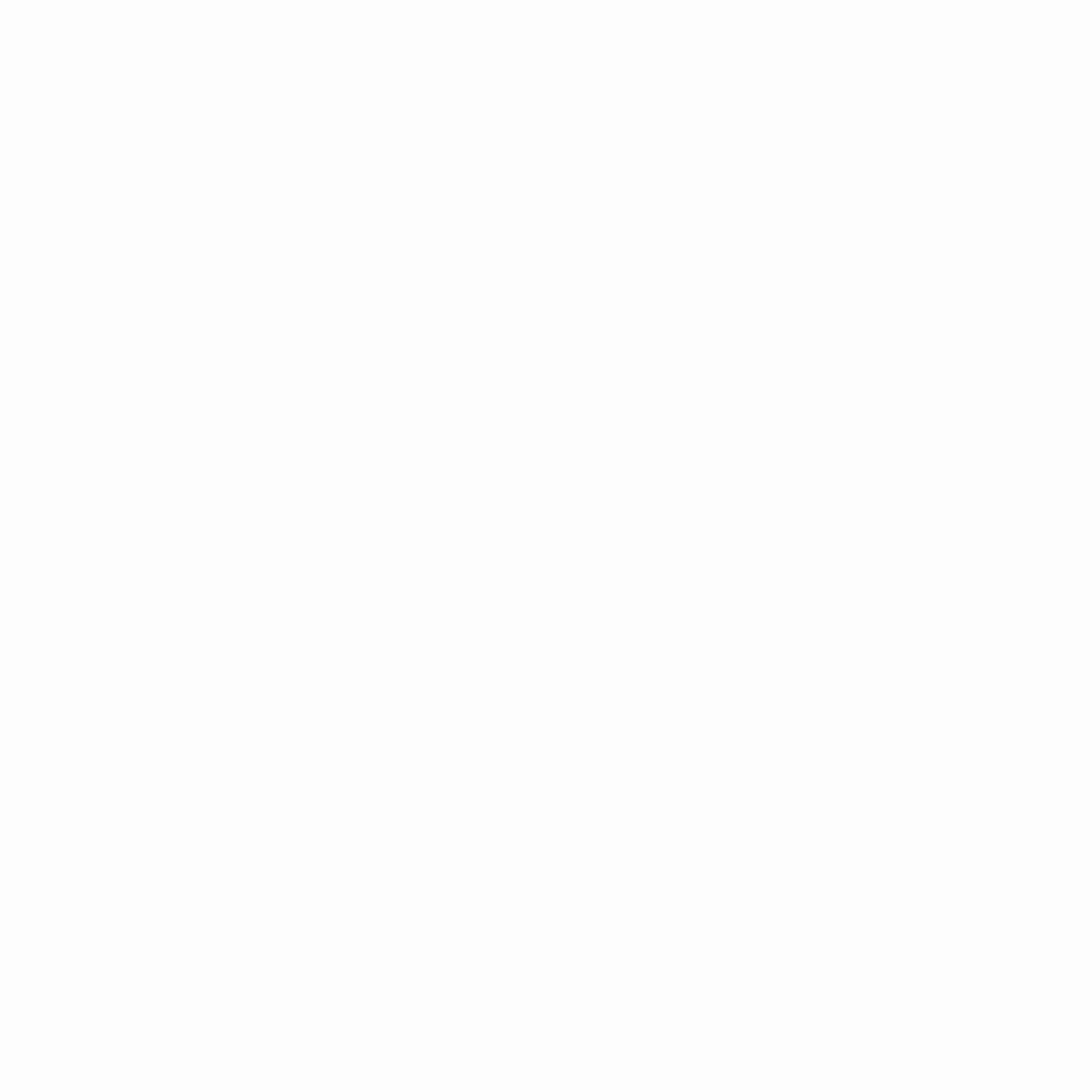
La Festa di San Giovanni Battista a Torino: tra religione e leggende popolari
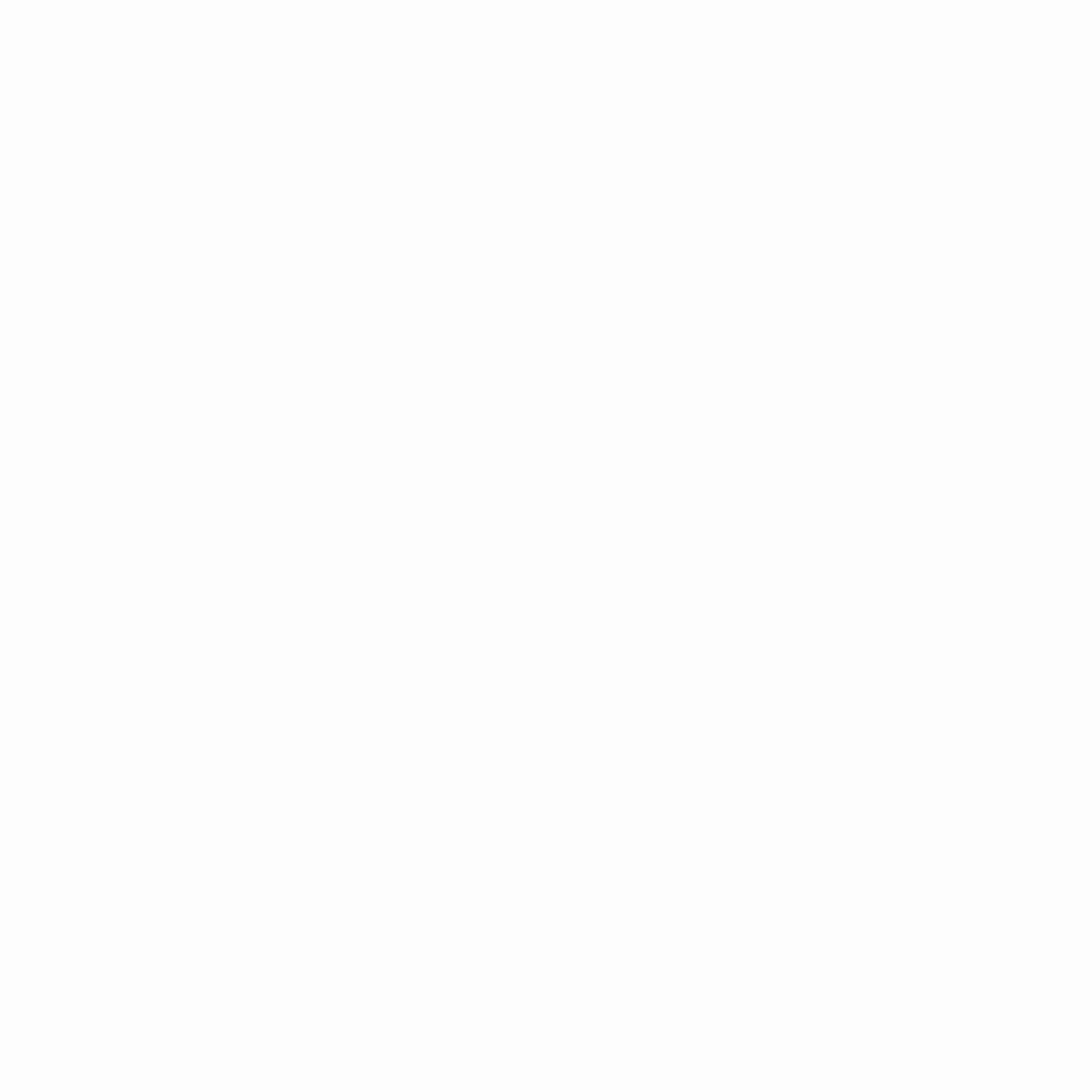
Share This Article
La Festa di San Giovanni Battista, patrono di Torino, è molto più di una semplice celebrazione religiosa; è un evento profondamente radicato nell’identità della città, un crocevia di fede, storia millenaria e leggende popolari che ogni anno, il 24 giugno, infiammano il cuore dei torinesi e richiamano visitatori da ogni dove, configurandosi come una delle tradizioni più note di tutta la Penisola.
Questa ricorrenza non è solo un omaggio al Santo precursore, ma anche un’eco di antichi riti pagani legati al solstizio d’estate, un momento di purificazione, rinascita e speranza.
Dal solstizio ai rituali cristiani
La scelta di San Giovanni Battista come patrono di Torino non è casuale. La data del 24 giugno, in prossimità del solstizio d’estate (21 giugno), non è solo la ricorrenza della nascita del Battista, ma coincide con un periodo dell’anno da sempre carico di significati magici e simbolici. Molte culture pre-cristiane celebravano in questi giorni il trionfo della luce sulle tenebre, la fertilità della terra e il potere purificatore del fuoco.
Falò, riti propiziatori e raccolta di erbe medicinali erano pratiche comuni in tutta Europa.
Quando il Cristianesimo si affermò, molte di queste tradizioni furono inglobate e cristianizzate. Così, il fuoco, simbolo pagano di purificazione e allontanamento degli spiriti maligni, divenne il “farò” (falò) di San Giovanni, e le erbe curative si trasformarono nelle “erbe di San Giovanni”, associate alla protezione divina. Torino, con la sua storia millenaria e la sua profonda religiosità, ha saputo conservare e tramandare questo sincretismo in una festa che è, allo stesso tempo, solenne e profondamente popolare, non solo in Piemonte, ma come detto in precedenza, in tutta Italia.
Fede e tradizione
Il cuore delle celebrazioni religiose si svolge presso il Duomo di San Giovanni Battista, dove si celebra una solenne messa in onore del patrono. La giornata è scandita da riti e processioni che culminano con la traslazione delle reliquie del Santo. Il momento più suggestivo è spesso la processione notturna, un antico rito che vede i partecipanti sfilare per le vie della città portando fiaccole e candele. Questo gesto simbolico ricorda la figura di San Giovanni e illumina le strade con una suggestiva scia di fede e devozione.
La partecipazione a questi eventi è sentita e coinvolge gran parte della popolazione, testimoniando la profonda devozione verso il Santo, protettore della città e simbolo di rinnovamento spirituale.
Il “Farò” di San Giovanni
Il momento culminante della Festa di San Giovanni a Torino è indubbiamente l’accensione del “Farò”, il grande falò che viene allestito in Piazza Castello (o, in passato, in altri luoghi simbolo della città). Il fuoco, come accennato, ha una valenza duplice: è un rito propiziatorio ereditato da pratiche precristiane e un simbolo cristiano di purificazione.
L’accensione del falò è un evento centrale per la comunità. Vengono bruciati oggetti vecchi e inutili per simboleggiare l’allontanamento del male e l’inizio di un nuovo ciclo. Si credeva che saltare sopra le braci del falò portasse fortuna e purificasse da ogni male. Oggi il “Farò” è un grande spettacolo, un momento di aggregazione che precede i fuochi d’artificio. La legna viene disposta in una catasta imponente, e la sua accensione, spesso seguita da musiche e canti, è un rito collettivo che unisce la città. In cima viene posto il simbolo del toro, che cadendo annuncia fortuna o un anno funesto, a seconda della direzione (Porta Nuova o Palazzo Reale).
Lo spettacolo dei fuochi d’artificio e le tradizioni gastranomiche
Dopo l’emozione del falò, la serata prosegue con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. I fuochi d’artificio sul fiume Po, con lo sfondo della Mole Antonelliana e della collina torinese, sono un’attrazione che ogni anno richiama migliaia di persone.
È un momento di festa pura, di meraviglia collettiva, in cui il cielo di Torino si accende di colori e luci, celebrando la vitalità della città e la gioia di ritrovarsi insieme. Questo evento, pur essendo una tradizione più moderna rispetto al falò, è diventato un elemento irrinunciabile della Festa di San Giovanni, unendo il fascino antico del fuoco alla spettacolarità contemporanea.
L’appuntamento non sarebbe completo senza le sue tradizioni culinarie. La cucina piemontese offre piatti specifici legati a questa ricorrenza, spesso semplici ma ricchi di gusto e significato. Tra i più popolari troviamo i tomini con bagnetto verde e rosso, un classico antipasto regionale, accompagnati da due salse a base di prezzemolo, aglio, acciughe o pomodoro.
A questi si aggiungono i fagioli con le cotiche o fagioli con tonno e cipolla, piatti robusti e saporiti, simbolo di abbondanza e convivialità, e le acciughe al verde, un’altra tipica preparazione piemontese, con le acciughe dissalate e condite con la già citata salsa verde.
Le leggende popolari
La notte di San Giovanni è, per eccellenza, la notte della magia e delle leggende popolari, un momento in cui il confine tra il mondo terreno e quello spirituale sembra assottigliarsi.
Tra le leggende più famose troviamo quella della “rugiada di San Giovanni”. Si crede che la rugiada che si posa sulle piante la notte tra il 23 e il 24 giugno abbia proprietà miracolose. Raccoglierla al mattino presto e lavarsi con essa porterebbe bellezza, fortuna e guarigione. È un rito antico, legato alla purificazione e al potere rigenerante dell’acqua.
Inoltre, le “erbe magiche” raccolte in questa notte sono un elemento centrale delle credenze popolari. Tra queste spicca l’Iperico (o Erba di San Giovanni), ritenuta protettiva contro il male e con proprietà curative. Ma anche le foglie di noce (per il nocino), l’aglio, la verbena, l’artemisia e la ruta venivano raccolte per preparare infusi, amuleti o “acqua di San Giovanni” (un’acqua lasciata all’aperto la notte con diverse erbe e fiori per assorbirne le virtù). Si riteneva che appendere ghirlande di queste erbe alle porte proteggesse la casa.
La notte di San Giovanni era considerata propizia anche per scoprire il proprio futuro, soprattutto in amore. Un rito comune prevedeva di mettere un albume d’uovo in un bicchiere d’acqua e lasciarlo sul davanzale tutta la notte; le forme che assumeva l’albume all’alba avrebbero rivelato il destino amoroso. Altre pratiche includevano l’accensione di candele galleggianti per predire il futuro.Infine, era anche considerata una notte in cui le streghe e gli spiriti maligni erano più attivi. Il falò serviva anche a scacciare queste presenze indesiderate, e l’aglio o le erbe protettive erano usati come amuleti.


