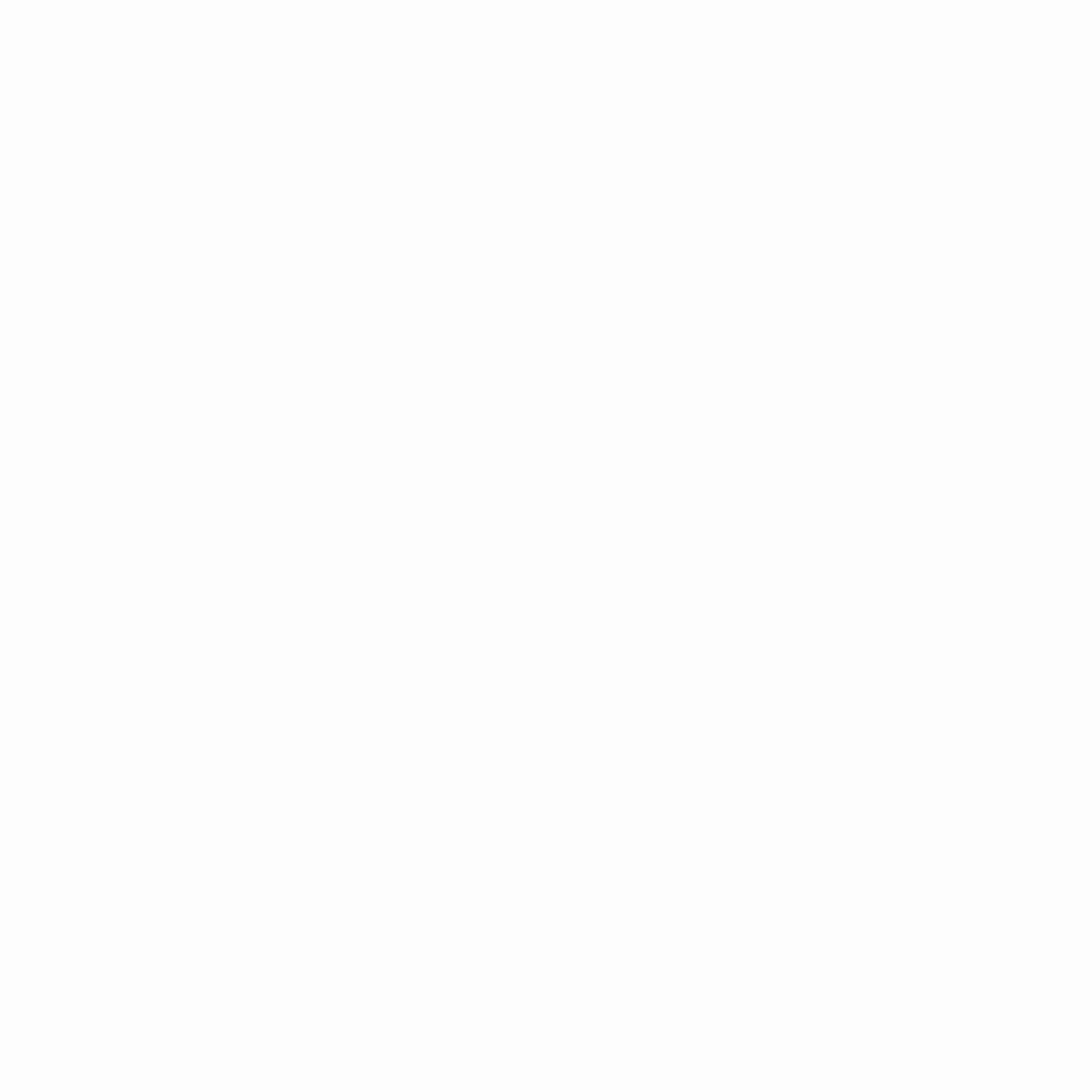
La storia del gianduiotto
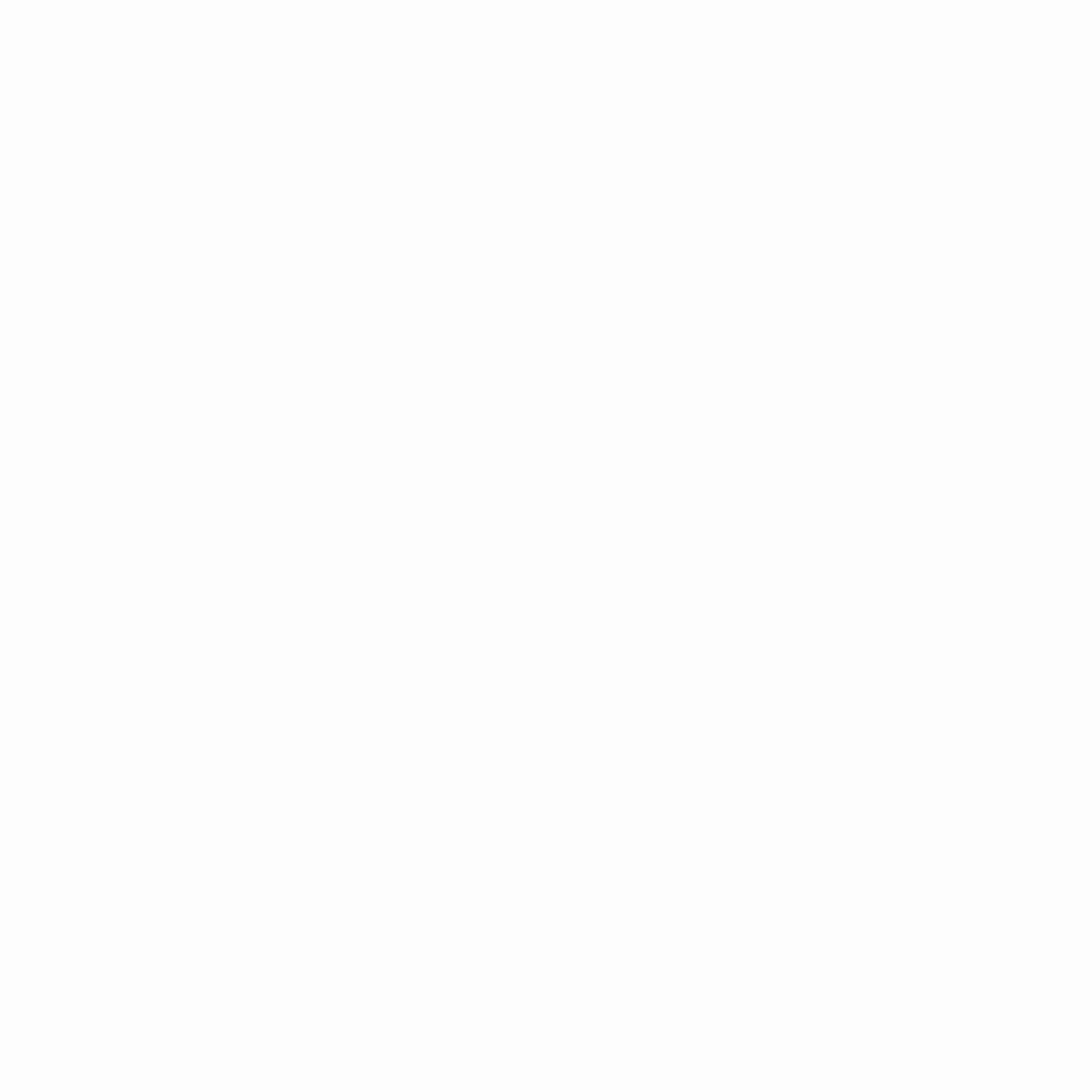
Share This Article
Il gianduiotto, con la sua inconfondibile forma a prisma triangolare e il suo sapore vellutato di cioccolato e nocciole, non è solo un dolce, ma un simbolo dell’eccellenza cioccolatiera del Piemonte, una vera e propria icona della città di Torino.
La sua storia è affascinante, intrisa di necessità storiche, ingegno imprenditoriale e un pizzico di allegria carnevalesca, che lo hanno reso uno dei cioccolatini più amati e riconosciuti al mondo.
Le origini: una crisi trasformata in opportunità
La nascita del gianduiotto trova origine in un periodo di grandi sconvolgimenti storici: le Guerre Napoleoniche e il conseguente blocco continentale imposto da Napoleone Bonaparte all’inizio del XIX secolo (precisamente nel 1806). Questa misura, volta a isolare economicamente la Gran Bretagna, ebbe ripercussioni significative su tutto il continente europeo, inclusa la disponibilità di materie prime esotiche come il cacao, che diventò estremamente scarso e costoso.
Torino, che già dal 1559, con l’arrivo dei primi semi di cacao portati da Emanuele Filiberto di Savoia, aveva sviluppato una fiorente tradizione cioccolatiera, si trovò di fronte a una grave crisi. I maestri cioccolatai torinesi, abituati a produrre grandi quantità di cioccolato al giorno, furono costretti a cercare soluzioni creative per far fronte alla penuria di cacao e soddisfare la domanda sempre crescente dell’aristocrazia e della borghesia locale.
Fu in questo contesto di necessità che nacque un’idea geniale: sostituire parte del costoso cacao con un prodotto abbondante e di altissima qualità disponibile localmente: la nocciola. Nelle Langhe piemontesi, infatti, prosperava la nocciola tonda gentile, oggi riconosciuta come “Nocciola Piemonte IGP”, una varietà celebre per il suo aroma intenso e la sua capacità di conservarsi a lungo.
La nascita della pasta gianduia e l’intuizione di Michele Prochet
L’idea di unire cioccolato e nocciole era già presente in qualche forma, ma fu grazie all’intuizione e all’innovazione di Michele Prochet, allora a capo della prestigiosa azienda dolciaria Caffarel (che esiste tutt’ora), che questa combinazione si perfezionò e si concretizzò nel prodotto che conosciamo oggi.
Nel 1852 (sebbene alcune fonti citino il 1865 come anno della prima produzione commerciale), Prochet perfezionò la ricetta della “pasta gianduia”, miscelando cacao, zucchero e una generosa quantità di nocciole tostate finemente macinate, un prodotto che risultava più morbido e vellutato rispetto al cioccolato tradizionale, e il suo sapore era un equilibrio sublime tra l’amaro del cacao e la dolcezza aromatica della nocciola.
L’introduzione delle nocciole non fu solo una soluzione alla scarsità di cacao, ma un’autentica rivoluzione del gusto, che diede vita a un cioccolato dal sapore unico e distintivo, profondamente legato al territorio piemontese.
Dal “Givù” al gianduiotto: il ruolo del Carnevale
Inizialmente, i cioccolatini prodotti con questa nuova pasta furono chiamati “givù“, termine piemontese che significa “mozzicone di sigaro“, probabilmente a causa della loro forma allungata. Tuttavia, la vera consacrazione del cioccolatino avvenne in un momento di grande festa e visibilità, il Carnevale.
Siamo nel 1865 (o 1867) e, durante le celebrazioni carnevalesche a Torino, fu la maschera tradizionale piemontese, Gianduja, a distribuire per la prima volta questi nuovi e deliziosi cioccolatini alla folla. Il personaggio, con la sua allegria, il suo tricorno e la sua bottiglia di vino, era una figura amata e benvoluta, simbolo dello spirito sabaudo. La sua associazione diretta con questi dolcetti ne decretò il successo e ne ispirò il nome. Fu così che i “givù” divennero i celebri Gianduiotti, ereditando il nome dalla maschera che li aveva resi famosi, con una mossa di marketing, se così si può chiamare, che fu geniale e contribuì enormemente alla loro popolarità.
La produzione e il confezionamento singolo
Un altro aspetto rivoluzionario legato al gianduiotto fu la sua tecnica di produzione e confezionamento. I gianduiotti furono i primi cioccolatini ad essere incartati singolarmente. Un’innovazione che, oltre a garantire igiene e conservazione, rendeva il gianduiotto un prodotto più pratico e facile da distribuire, ideale per essere offerto e consumato in qualsiasi occasione.
La loro peculiare forma a “barchetta rovesciata” o “prisma triangolare” non fu casuale. Essa venne creata attraverso un processo di estrusione, che permetteva di ottenere un prodotto morbido e vellutato senza la necessità di stampi complessi. Ancora oggi, alcune produzioni artigianali mantengono il taglio a mano, una tecnica che richiede grande abilità per ottenere la forma perfetta, mentre la produzione industriale utilizza macchinari che lavorano l’impasto estruso per replicare la forma tradizionale.
L’Espansione e il Riconoscimento Internazionale
Dopo la sua “presentazione ufficiale” al Carnevale e il successo riscosso, il gianduiotto iniziò a diffondersi rapidamente. L’unione nel 1879 tra la Prochet e la Caffarel consolidò la leadership nel settore e permise al cioccolatino di ottenere importanti riconoscimenti nelle Esposizioni Universali dell’epoca, affermandosi come prodotto di eccellenza.
Altre storiche aziende cioccolatiere torinesi, come Pernigotti, Peyrano, Streglio, Novi, Venchi, tanto per citarne alcune, hanno successivamente incluso il gianduiotto nella loro produzione, contribuendo a rafforzarne l’immagine e a diffonderne il gusto in Italia e nel mondo. Ogni produttore ha la sua ricetta, spesso custodita gelosamente, con piccole variazioni nelle proporzioni di cacao, zucchero e nocciole, che conferiscono al proprio gianduiotto una personalità unica, sebbene la percentuale della nocciola piemontese si assesti sempre intorno al 28-30%.
Il gianduiotto oggi tra tradizione e tutela
Oggi il gianduiotto rimane un simbolo indiscusso della tradizione dolciaria piemontese. È un prodotto che evoca artigianalità, qualità e un legame profondo con il territorio. La nocciola del Piemonte IGP è un ingrediente fondamentale e la sua tracciabilità è garantita da consorzi e disciplinari.
Vi sono discussioni e sforzi per ottenere il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per il gianduiotto di Torino, un passo che tutelerebbe ulteriormente la sua origine e la sua ricetta tradizionale, salvaguardandolo da imitazioni e garantendo la massima qualità al consumatore.
Il cioccolatino viene gustato in molteplici modi: da solo, come piccolo piacere quotidiano, accompagnato da un caffè, oppure come ingrediente in altre preparazioni di pasticceria, con la sua consistenza morbida e avvolgente che si scioglie in bocca e il suo sapore che lo rendono un’esperienza sensoriale unica.


